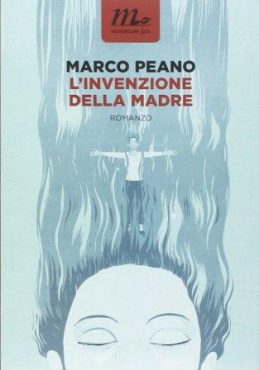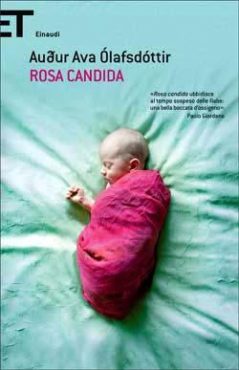Rimaste orfane e cresciute alla bell’e meglio dalla zia materna, Ruth e Lucille crescono come eremite lontane dalla società e dai loro coetanei, forti l’una della presenza dell’altra, fino a quando la loro indole non le porta a fare scelte di vita molto diverse…
Pubblicato nel 1980 e vincitore del Premio PEN/Hemingway Award per il miglior romanzo d’esordio, Le cure domestiche è un romanzo sul senso della perdita, sull’essere orfani, sul sentirsi in un perenne stato di precarietà e incertezza.
Ruth e Lucille sono due bambine che hanno conosciuto sulla propria pelle il significato della parola “abbandono”. Della madre, di cui serbano un ricordo incerto, si interrogano sulla natura instabile: dopo averle lasciate sulla veranda della casa materna si suicida gettandosi nel lago da un dirupo. Del padre noi lettori sappiamo poco o nulla e non è che le due piccole diano segni di sentirne la mancanza.
Cresciute dalla nonna prima e dalle anziane prozie nubili poi, alla fine rincorrono il sogno di avere una famiglia quando per occuparsi di loro arriva la zia Sylvie. Anche lei, come le altre donne della famiglia, ha un’indole inquieta, malinconica, sempre orientata ad un oltre difficile (se non impossibile) da raggiungere. Sylvie è una vagabonda e quel suo stile di vita ramingo e solitario non si confà al ruolo di madre di famiglia attenta e premurosa. E proprio le cure domestiche del titolo non sono il suo forte, ma fa quel che può, assurgendo a un compito che le è stato imposto ma che non ha scelto.
Si può dire che in questo romanzo nessun adulto trasmetta il senso di protezione che chiedono e meritano le due bambine. Sembrano barche in mezzo al lago – quel lago che segna il destino di quasi tutti i membri della famiglia – in balia della corrente, trascinate da un vento – che è poi quello che spira vigoroso a Fingerbone – che le riporta ad un passato di morte.
E in effetti a segnare il loro destino incombono le morti del nonno, della madre Helen e della nonna, figure che ricompaiono continuamente tra queste pagine come fantasmi, presenze familiari che si aggirano nei dintorni e negli incubi delle protagoniste, minando la loro serenità emotiva. È Ruth, io narrante, a descrivere la condizione di stasi e di timore che le cose cambino (o che non cambino affatto).
Se mai avessi dovuto lamentarmi di qualcosa di preciso, era che la mia vita sembrava fatta interamente di attesa. Io aspettavo un arrivo, una spiegazione, delle scuse. Non erano mai arrivati e avrei potuto adattarmici, non fosse che, proprio quando mi ero abituata ai limiti e alle dimensioni di un momento, venivo catapultata nel successivo e costretta a chiedermi ancora una volta se nella sua ombra non si nascondesse qualche forma. Che tutti i momenti fossero perlopiù identici non toglieva niente alla possibilità che il momento successivo potere essere completamente diverso. E così il quotidiano esigeva attenzione ininterrotta.
A trasmettere quel senso di cupa desolazione, Marilynne Robinson tratteggia uno scenario del tutto inospitale, dove il sole è oscurato da un cielo plumbeo carico di pioggia e neve e le giornate si ripetono tutte uguali in attesa di tempi migliori.
Marilynne Robinson ci racconta questa storia tormentata con uno stile ricercato e poetico, impreziosito da riferimenti biblici. Un romanzo che richiede attenzione e pazienza.
Dal canto mio, priva di queste doti e amante di storie meno riflessive e più movimentate, ho trovato certe parti un po’ troppo nebulose e lente e molti quesiti non risolti. Ma nel complesso un libro pienamente riuscito.