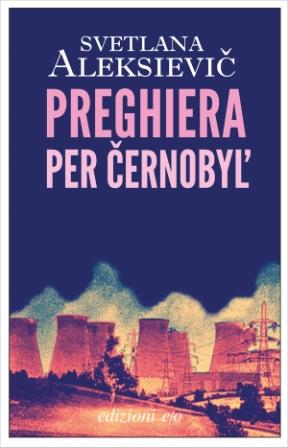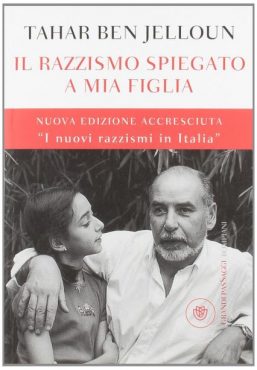La giornalista e scrittrice bielorussa racconta le conseguenze derivate dall’esplosione avvenuta nella notte del 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Černobyl’
In Preghiera per Černobyl’, Svetlana Aleksievič, Premio Nobel per la Letteratura nel 2015, dà voce alle persone che non hanno avuto la possibilità di esprimersi, di raccontare cosa hanno visto e cosa hanno provato, pur essendo state loro le vittime di una tragedia umana indicibile. Persone a cui il potere ha tentato di chiudere la bocca perché dietro alla morte di migliaia di uomini e di bambini si cela un puro interesse politico: niente, neanche la tragedia, doveva scalfire il nome del potente Stato russo.
Cambiò il mondo. Cambiò il nemico, la morte ebbe facce nuove che non conoscevamo ancora. Non si vedeva, la morte, non si toccava, non aveva odore. Mancavano perfino le parole, per raccontare della gente che aveva paura dell’acqua, della terra, dei fiori, degli alberi. Perché niente di simile era mai accaduto, prima. Le cose erano le stesse – i fiori avevano la solita forma, il solito odore – eppure potevano uccidere. Il mondo era il solito e non era più lo stesso. Lo strato superiore di chilometri di terra infetta venne divelto e sotterrato in sarcofagi di cemento. La terra venne sepolta nella terra. Vennero sepolte le case, le macchine…
Oggi conosciamo per sommi capi i danni del disastro conseguente all’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare di Černobyl’, ma allora, a poche ore, a pochi giorni, perfino a qualche mese dall’esplosione non era chiara la portata delle ripercussioni che quell’incidente ha significato per l’ambiente, per gli animali e soprattutto per le persone che abitavano nel raggio di chilometri dal sito. E per molto tempo il solo desiderio delle persone evacuate era di tornare nella propria casa, a coltivare la propria terra, ad accudire la propria casa.
Leggi queste pagine e rabbrividisci pensando all’ignoranza in cui viveva questa gente (tutte le informazioni in merito erano rigorosamente top secret). Leggi di persone che hanno tentato di corrompere i soldati pur di tornare a prendere un televisore o un materasso, a raccogliere le patate, a portar via la vacca o il gatto, senza sapere che ogni oggetto e ogni essere vivente era intriso di radiazioni e, perciò, potenzialmente mortale.
Il loro è un suicidio. “Ritorneremo” e “Perdonaci, casetta nostra”: queste scritte pitturate sulle porte delle abitazioni sono il segno dell’amore incondizionato per la propria terra.
Sono molte le persone intervistate dalla Aleksievič: militari e uomini qualunque chiamati a spegnere l’incendio o a decontaminare la zona circostante, le loro mogli, le madri di bambini malati o morti, vecchi che non si sono piegati a evacuare la casa, bambini che hanno perso un genitore o che non hanno conosciuto altra casa che l’ospedale.
Molti di loro hanno paragonato l’esperienza di Černobyl’ alla guerra, e se questa fa paura, almeno è comprensibile; quella delle radiazioni invece è una guerra atomica che non si conosce e non si può combattere perché non sai da dove arriverà l’attacco mortale, ma sai che la fine è vicina.
Ci dicevano che dovevamo vincere. Ma vincere cosa? L’atomo? La fisica? Il cosmo? Da noi la vittoria non è un evento, ma un processo. La vita è una lotta. Un superamento.
Eppure per noi che ce ne stiamo comodamente a leggere queste testimonianze come se fossero qualcosa di lontano, di estraneo alla nostra vita, queste voci sono qualcosa di poetico, di eroico. Ed è proprio per non dimenticare che leggere queste pagine è un atto dovuto a quanti hanno perso la vita o che lottano tuttora contro un male che ha causato malformazioni, sterilità, tumori, e che mieterà altre vittime ancora per decenni.