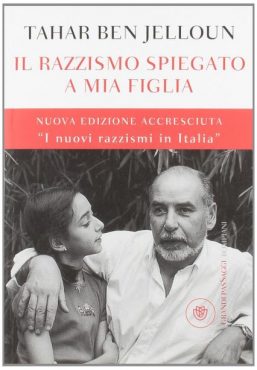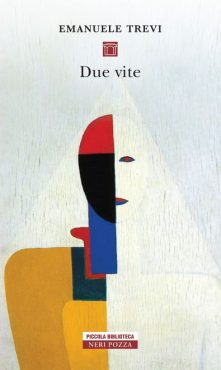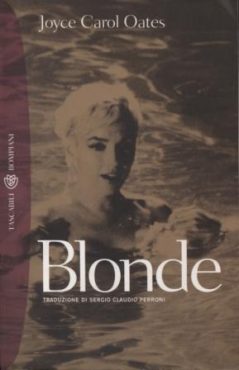Rapito in Argentina dai servizi segreti israeliani, Adolf Eichmann viene portato a Gerusalemme con un espediente e processato per crimini di guerra e contro il popolo ebraico. Hannah Arendt, reporter per il “New Yorker”, analizza accuratamente ogni sfumatura del dibattito in corso.
La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme di Hannah Arendt è un saggio scomodo, che in qualche modo nobilita il mostro.
Nell’immaginario collettivo colui che è stato artefice di una deportazione di massa dalle conseguenze devastanti non può che essere una figura sicura di sé, autoritaria, per non dire carismatica. Viceversa, dal quadro tratteggiato dalla Arendt, Eichmann non è che una rotella dell’ingranaggio della macchina della morte, uno dei tanti che si è sottomesso al potere, un uomo con tante aspirazioni personali mai realizzate.
Contrariamente a quanto si pensi, non è sua l’iniziativa dello sterminio degli ebrei; il suo progetto è una ghettizzazione universale di tutta la razza ebraica, un trasferimento su scala mondiale nel Madagascar.
È forte la delusione quando gli riferiscono che gli ordini sono cambiati; “soluzione finale” la chiamano e, nonostante le sue personali riserve, esegue il compito che gli è stato affidato – e sì, lo compie al meglio delle sue possibilità ed è qui che sta la banalità del male.
Il suddito di un governo buono è fortunato, il suddito di un governo cattivo è sfortunato: io non ho avuto fortuna.
Eichmann così come ci viene presentato in queste pagine non è un sadico, non prova godimento nel vedere la morte dei suoi presunti nemici. Mentre attraversa il campo di concentramento di Warthegau ha un malore di fronte ai cadaveri ancora flessibili scaraventati in una fossa comune; quando è in visita ad Auschwitz, evita accuratamente il reparto di sterminio. Conosce le procedure e si assicura che tutto fili liscio, ma non è lui la mente maligna che ha dato inizio all’orrore.
Naturalmente Eichmann sapeva che la stragrande maggioranza delle sue vittime erano condannate a morte; ma […] la verità era che egli non aveva alcuna autorità per stabilire chi doveva morire e chi doveva vivere, e neppure sapeva chi sarebbe morto e chi si sarebbe salvato.
Un fattore che durante il processo gioca a suo sfavore è il fatto che Eichmann non è un buon oratore: la sua difesa sembra una lezione imparata a memoria per compiacere qualcuno (e se stesso). Se è vero che si è più volte vantato pubblicamente (soprattutto durante l’esilio in Argentina) dei sei milioni di ebrei uccisi, lo ha fatto forse per darsi un tono che tutto sommato non merita affatto.
In questo resoconto, la Arendt mette in luce le manchevolezze della difesa e la scarsa memoria di Eichmann che forse avrebbe potuto giocare un ruolo fondamentale nella decisione finale (dimentica, per esempio, di accennare a episodi che dimostrerebbero i suoi buoni rapporti con alcuni ebrei e perfino di averne aiutato qualcuno).
Un processo tutt’altro che imparziale quello subito da Eichmann che, se si fosse tenuto in un luogo e con modalità diverse, avrebbe potuto avere un esito diverso. Secondo l’autrice, in definitiva il popolo ebraico ha avuto il suo capro espiatorio su cui infierire per avere una seppur inutile vendetta per le ferite subite.
Hannah Arendt
La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme
Feltrinelli, 2013
pp. 320