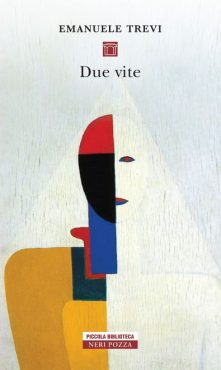Figlia di una coppia di sordi, l’autrice cresce tra gli Stati Uniti e la Basilicata finché non sceglie di trasferirsi a Londra. Claudia è un’immigrata al contrario, e ovunque vada sente di non appartenere a nessun luogo.
Con La straniera Claudia Durastanti si è aggiudicata un posto nella cinquina del Premio Strega di quest’anno, ed è proprio questo il libro su cui avevo calamitato tutte le mie aspettative. Finalmente l’ho letto, e che dire? Una delusione inaudita.
La Durastanti racconta le sue origini, a partire dall’infanzia dei suoi genitori, entrambi sordi per motivi diversi, fino al loro incontro riportato così come le è stato raccontato, secondo due versioni opposte ma in un certo senso ugualmente veritiere: di fondo resta l’incontro di due solitudini bisognose di condividere lo stesso disagio.
L’autrice non cerca di abbellire la realtà, tant’è che nessuno si salva del tutto dal biasimo del lettore, men che meno l’autrice stessa. Una famiglia poco unita, verrebbe da dire, disgregata, divisa tra l’Italia e l’America.
Quando una città ci respinge, quando non riusciamo a entrare nei suoi meccanismi più profondi e siamo sempre dall’altra parte del vetro, subentra una sensazione frustrata di merito, che può farsi malattia. Straniero è una parola bellissima, se nessuno ti costringe a esserlo; il resto del tempo, è solo il sinonimo di una mutilazione, e un colpo di pistola che ci siamo sparati da soli.
Ma badi bene: non è tanto la distanza fisica a ferire, quanto quella affettiva. Un’incomunicabilità che poco ha a che fare con la sordità dei genitori, quanto con una loro ritrosia ad aprire un dialogo costruttivo e edificante con i figli.
All’inizio il libro mi ha preso moltissimo nonostante avvertissi qualcosa che mi respingeva, dovuto ad una scrittura ricercata che mi lasciava un po’ perplessa. Il limite tra stile raffinato e scrittura artefatta è sottilissimo e solo a metà ho iniziato ad essere insofferente per tutta quella pomposità che avvertivo come qualcosa di falso, di costruito. Pura ostentazione.
Non ha aiutato neanche il continuo passare da un argomento all’altro, tra un passato remoto e uno più recente, infarcendo il tutto di riflessioni culturali e pseudofilosofiche sulla disabilità, sul sentirsi fuori contesto, sull’amore, ma sempre senza continuità e linearità, senza coerenza.
Anche il fatto che l’autrice definisca il libro un memoir mi è sembrato un tantino pretenzioso. Chiamarlo autobiografia era troppo terra terra?
Insomma, un libro che non mi ha convinto, che non mi ha trasmesso nulla se non l’irritazione di non arrivare mai alla fine.