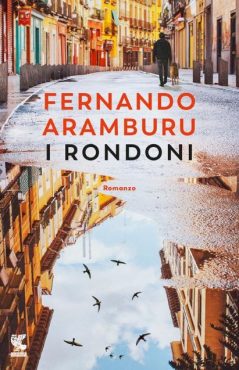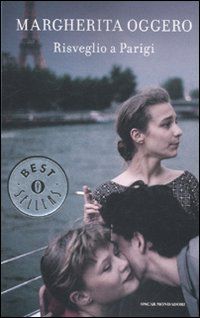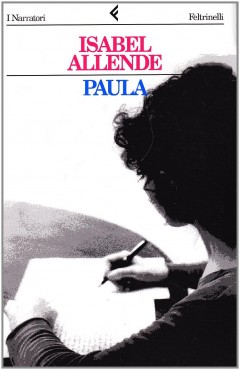Profondamente scontenta della sua vita nonostante abbia tutte le carte in regola per essere felice, la protagonista decide di passare un anno in stato letargico per smettere di provare emozioni e “ripulirsi” dalle delusioni passate.
Il mio anno di riposo e oblio è un romanzo di Ottessa Moshfegh che mette in luce una questione affascinante quanto problematica: si possono mettere in pausa le emozioni e dimenticare il dolore?
La protagonista è una ragazza giovane, carina e intelligente, si è da poco laureata alla Columbia, ha delle amicizie e una di queste, Riva, è particolarmente affezionata a lei. Ha un lavoro in una galleria d’arte (che a dire il vero espone opere discutibili) ed è ricca. Eppure non è felice. Ha una relazione con un uomo che dimostra di non tenere a lei, che scompare e ricompare a sua discrezione per soddisfare il proprio piacere.
Un motivo per stare male, a dire il vero, ci sarebbe. Ha perso entrambi i genitori a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra, eppure questo non sembra essere il più grande dolore della sua vita. A destabilizzarla è piuttosto uno stato di torpore, di malinconica insoddisfazione generale.
Per questo si convince che la cura migliore sia quella di passare un anno in stato vegetativo, imbottendosi di farmaci che la facciano dormire e perdere coscienza di sé e di quel che avviene intorno a lei. Il fatto che trovi una psichiatra tanto folle e incompetente da prescriverle oppiacei e antidepressivi con una superficialità disarmante la dice lunga sulla semplicità di reperire farmaci in America.
Il suo proposito si scontrerà con le conseguenze del mix di farmaci e sonniferi: allucinazioni, sogni che si confondono con la realtà e azioni compiute nel sonno o in stato di trance di cui non ha memoria.
Dormire mi sembrava produttivo, come se qualcosa venisse risolto. Sapevo in fondo al cuore – e questa era forse l’unica cosa che sapevo in quel periodo – che se fossi riuscita a dormire abbastanza sarei stata bene. Mi sarei sentita rinata, nuova. Avrei potuto diventare un’altra persona, ogni cellula rigenerata tante volte così che quelle vecchie sarebbero state solo memorie sfocate, distanti. La mia vita passata sarebbe stata solo un sogno, e avrei potuto ricominciare senza rimpianti, rafforzata dalla beatitudine e dalla serenità accumulata nel mio anno di riposo e oblio.
“Esilarante” è la prima parola che si trova nella banda descrittiva, termine che secondo me non definisce minimamente la natura di questo romanzo. Cinico piuttosto. Una critica spietata alla società menefreghista newyorkese, dove puoi decidere di autodistruggerti liberamente perché nessuno – nemmeno l’analista che ti ha in cura – farà nulla per rimetterti in carreggiata e salvarti dall’autodistruzione.
In fondo nessuno si salva in questo romanzo. Gli unici due esemplari maschili sono degli opportunisti interessati solo alle prestazioni sessuali delle loro amanti; l’amica Reva nasconde un’invidia recondita e non mostra grande sensibilità per la situazione dell’amica e la protagonista stessa non brilla certo per simpatia né per altruismo.
La prima parte del romanzo devo dire che è molto intrigante perché davvero a tutti prima o poi viene il desiderio di dormire così a lungo da scavallare un periodo difficile, per riprendersi da una delusione o semplicemente per ricaricarsi. È inevitabile quindi che le aspettative sulle vicissitudini di questa stramba bella addormentata fossero alte.
A metà però ho iniziato ad annoiarmi perché in fin dei conti non succede niente di inaspettato o veramente rilevante, solo una sequenza di episodi recuperati nei suoi brevi momenti di lucidità.
E anche sul finale sono rimasta un po’ delusa. A che conclusione vuole arrivare l’autrice? Qual è, in fin dei conti, la morale del libro? Se intraprendi un viaggio così impervio, devi saperne uscire degnamente. Peccato!