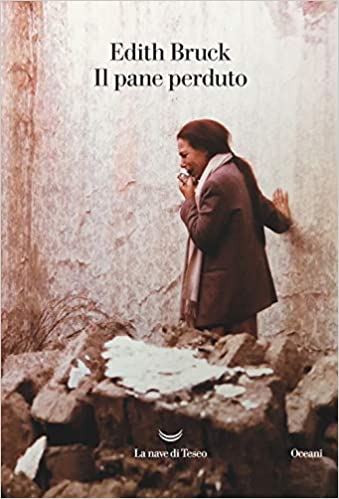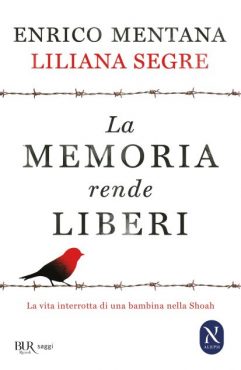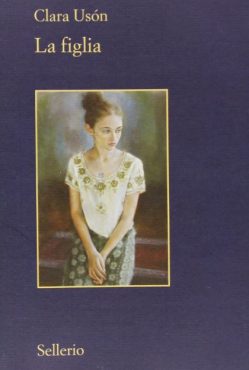A 90 anni, Edith Bruck continua a fare della sua vita un monito, a raccontare l’esperienza drammatica del lager e quella altrettanto tragica del ritorno alla vita, tra gente che troppo spesso non è preparata ad ascoltare e capire veramente cosa è avvenuto all’interno di quei recinti spinati.
Il pane perduto è l’ultimo romanzo della scrittrice e poetessa ungherese Edith Bruck che racconta in poco più di cento pagine la vita di questa scrittrice, scampata ai campi di sterminio.
Racconta, non ci crederanno, racconta, se sopravvivi, anche per noi.
Il romanzo è diviso in sei capitoli ciascuno dei quali inquadra un periodo della sua vita: dall’infanzia in una famiglia ebrea povera ma felice, al trasferimento nei campi di sterminio di Auschwitz, di Dachau e di Bergen Belsen, fino alla lunga odissea del ritorno a casa.
Non c’era tempo né per piangere, né per parlare, solo per stare attenti ai passi e ai bambini che potevano sfuggire dalle mani tremanti dei genitori, per sostenere i più vecchi che barcollavano come ubriachi e ciechi. Sembrava l’esodo dall’Egitto senza un Mosè, senza che apparisse l’Eterno, e invece del Mar Rosso si aprirono con un rumore lacerante i vagoni per bestiame, e la mandria umana veniva spinta dentro con violenza.
Tutta la seconda parte del romanzo è incentrata sul ritorno alla vita, sull’incapacità di riadattarsi alla realtà, al vivere in società.
Tornare a casa è scoprire che una casa non c’è più, che una famiglia non c’è più. Ad attenderla ci sono gli atteggiamenti ostili di chi è rimasto, di chi evita di incrociare lo sguardo dei sopravvissuti per rancore, per paura o semplicemente per il senso di colpa di non aver fatto niente per impedire la deportazione di compaesani, di amici.
Perfino tra le braccia delle sorelle maggiori scampate all’orrore, Edith non trova il calore e il conforto che cerca. E così si mette in viaggio per cercare un luogo dove mettere radici, tra il neonato Stato di Israele, Atene, Istanbul, Zurigo, Napoli; e il destino prima e l’amore poi portano Edith a scegliere di fermarsi nel nostro Paese e a raccontare di sé, della sua storia uguale a quella di tanti altri.
Questo libro è una delle poche testimonianze di una donna ancora in vita, impegnata a far sì che la memoria resti vigile affinché quanto è avvenuto non possa ripetersi. Ma al di là dell’importanza di questa testimonianza, il libro non mi è sembrato più meritevole di tanti altri che ogni anno in occasione del Giorno della Memoria vengono suggeriti e riproposti – penso a L’amico ritrovato, il Diario di Anna Frank e Io non mi chiamo Miriam.
Forse per la sua estrema brevità, Il pane perduto finisce per essere una lunga corsa verso i giorni d’oggi, una corsa che lascia poco spazio per riflettere sulle dolorose tappe del suo viaggio. Eppure, credo che il bisogno viscerale dell’autrice di ripercorrere ancora una volta la sua vita sia racchiuso in quell’ultimo capitolo, una lettera a Dio affinché non la privi della memoria, unico strumento che le rimane per illuminare ancora le coscienze dei giovani d’oggi.