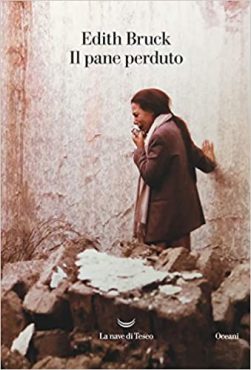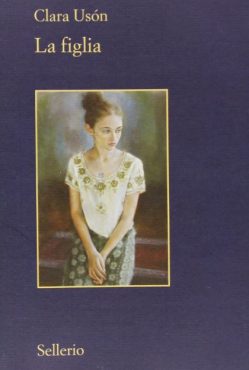Agli inizia del Novecento, un folto gruppo di ragazze giapponesi mandate in America per sposarsi vede svanire i sogni di un futuro roseo non appena scese sulla terraferma. Gli anni a seguire saranno per molte di loro un susseguirsi di qualche (rara) gioia e tanti dolori.
Quello raccontato dalla scrittrice Julie Otsuka in Venivamo tutte per mare è la storia di un viaggio per seguire un destino, l’inizio di una vita nuova, sconosciuta e che fa una gran paura. Sono tutte giapponesi quelle che vengono imbarcate in Giappone per approdare in America, e per tutto il tempo del viaggio in mare per loro c’è la speranza, la fiducia che l’America sia anche per loro terra di promesse e di felicità.
C’è chi si lascia indietro i genitori anziani, chi un figlio, chi un innamorato: nonostante questo partono per diventare mogli di uomini che non conoscono, che hanno visto solo in foto. Qualcuna di loro si innamora sulla nave, qualcun’altra si getta in mare per non dover andare in sposa a uno sconosciuto dopo aver conosciuto l’amore.
Poi l’arrivo e le speranze disattese. I futuri mariti sono più brutti o più vecchi di quanto apparivano in foto, non sono bancari ma braccianti che prendono moglie per avere un aiuto nei campi invece che per trovare una compagna per la vita.
Sulla nave non potevamo sapere che quando avremmo visto i nostri mariti non li avremmo riconosciuti […] Che le fotografie che ci avevano mandato erano vecchie di vent’anni. Che le lettere che ci avevano scritto erano state scritte da altri, professionisti della bella calligrafia che di mestiere raccontavano bugie e conquistavano cuori.
La vita matrimoniale è una delusione e tanta è la voglia di salire su un’altra nave e fare dietrofront, ma è preferibile essere infelici in America che tornare in patria con disonore.
Poi arrivano i figli, tanti, troppi, neanche fossero macchine create per riprodursi. E poi il rapporto coi bianchi, non sempre idilliaco: alcuni vogliono solo sottometterle, ma altri (pochi) sono gentili e si affezionano a loro.
Infine, la tragedia. Dopo l’attacco di Pearl Harbour, i giapponesi in America sono visti con sospetto, considerati spie assoldate dai nemici e da quel momento nessuno di loro avrà vita facile: vengono arrestati, interrogati, perseguitati e, infine, deportati in campi di lavoro.
Questo della Otsuka è un libro davvero toccante. Ma non è solo l’argomento ad essere coinvolgente, ma il modo di trattarlo. Ogni frase racchiude un mondo, un’esperienza vissuta e condivisa da alcune connazionali e da questa condivisione nasce una verità plurale, di tutte loro.
Da qui nasce la trovata di usare la prima persona plurale, un “noi” che pesa come un macigno nel ripercorrere la vita spesso tragica delle giovani giapponesi partite per trovare l’amore ma che hanno delle esperienze assimilabili.
Ma è lo stile la nota distintiva che impreziosisce queste pagine. Un continuo rimando tra “noi” e “loro”, dove loro sono qualche volta i mariti, qualche volta i bianchi e qualche altra i bambini.
Solo nell’ultimo capitolo le parti si invertono: l’io narrante ora è affidato agli americani, che trovano le loro città improvvisamente svuotate dai giapponesi deportati nei campi di lavoro e ne restano sorpresi come se non si fossero accorti di quello che progressivamente stava succedendo. Semplicemente per tutti loro vale la regola del “prima noi”, motivo per cui stanno a guardare la deportazione dei giapponesi, senza considerare le conseguenze, senza assumersene le responsabilità. In fondo la cosa non li riguarda.
Un finale che è un pugno nello stomaco, perché vuole essere un monito per quanti nascondono la testa sotto la sabbia senza alzare un dito per aiutare chi viene ingiustamente perseguitato…