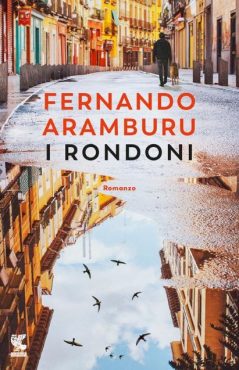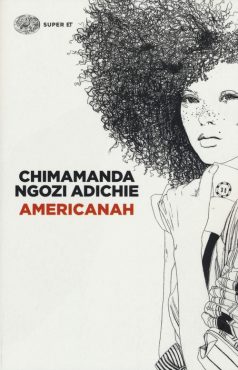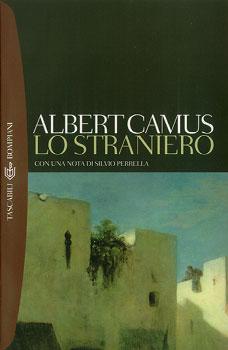In una Buenos Aires piovosa, tra febbraio e giugno, si consumano le vite di quattro persone che procedono indipendenti l’una dall’altra, ma sono accomunate dall’essere partecipanti più o meno attive di un omicidio.
Pubblicato nel 1969, Cicatrici è un romanzo dello scrittore argentino Juan José Saer diviso in quattro capitoli, ciascuno dei quali scritto in prima persona da un personaggio differente. A fare da collante alle vicende dei narratori è l’essere partecipi in modo più o meno marginale di un fatto di cronaca: l’omicidio di Marìa Antonia Pazzi de Fiore – detta “la Gringa” – per mano di suo marito Luis.
Ecco perciò che conosciamo Ángel, un giovanissimo reporter interessato a vedere in faccia un assassino. Di lui in realtà il lettore viene a conoscenza del rapporto difficile con la madre, con cui condivide la passione e l’abuso di alcolici e con la quale viene spesso alle mani.
Nel secondo racconto il protagonista è invece Sergio, un avvocato che ha rinunciato alla professione per dedicarsi anima e corpo al gioco d’azzardo. La sua ossessione si spinge a tal punto da essere disposto a impegnare qualsiasi oggetto di valore e a ipotecare la casa al dichiarato scopo di vivere con tranquillità la sua passione, consapevole dei rischi che corre. Il paradosso è che intorno a sé trova gente disposta a sovvenzionare il suo patologico vizio.
Ma è il terzo racconto quello più enigmatico. Il giudice Ernesto Garay è un personaggio solitario, che rifugge il contatto con gli altri uomini – che nella sua mente assumono le sembianze di gorilla goffi e patologicamente incline al sesso. La sua visione del mondo è contorta, a tratti persino allucinogena, e non sempre è facile seguirne le dinamiche, caratterizzate il più delle volte dal nonsense.
L’ultimo capitolo è quello raccontato in prima persona dall’assassino, Luis Fiore, ed è qui che ripercorriamo la giornata trascorsa dall’intera famiglia e le motivazioni che lo hanno spinto ad uccidere sua moglie.
Tutti e quattro i protagonisti del romanzo sono uomini soli, incapaci di maturare negli affetti, di intrattenere rapporti duraturi e altruistici. Se è il giudice Ernesto ad essere chiaramente etichettato come misantropo, non può dirsi diversamente di Ángel né dell’avvocato Sergio, entrambi inadatti a confrontarsi con l’altro, intrappolati in un rapporto sterile (il primo con la madre e il secondo con la giovanissima e remissiva domestica).
Il romanzo è in alcune parti forse troppo didascalico per i miei gusti e a tratti si dilunga sulle descrizioni di un ambiente o di un’azione in maniera quasi ossessiva – basti pensare alle dinamiche al tavolo da gioco o al ripetersi degli spostamenti in macchina del giudice.
Eppure, è proprio questa ripetitività delle azioni misurate e rallentate che fa sì che si crei una sorta di attesa, quasi un preludio ad un’epifania che da un momento all’altro travolgerà il protagonista e, con lui, il lettore.
Viceversa, niente di significativo può avvenire perché in quella monotonia e in quella ripetitività c’è tutta l’amarezza di una vita insensata, senza prospettive, che procede nel caos, senza che una reale crescita psicologica possa realmente avvenire. Una vita in cui è possibile incontrare per strada il proprio sosia, dove una cameriera estremamente alta viene assunta in un albergo per pulire i soffitti o in cui si è svegliati nel cuore della notte da telefonate anonime. Ma niente di ciò sembra perturbare i protagonisti, quasi non avessero un’anima da sconvolgere.
«Credo che la maturità non porti nessuna esperienza» disse. «O dovrei dire che l’esperienza non porta nessuna maturità?»