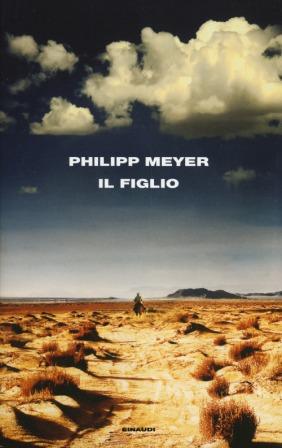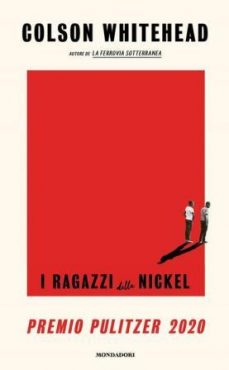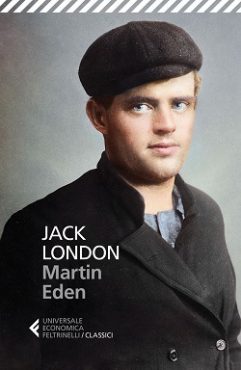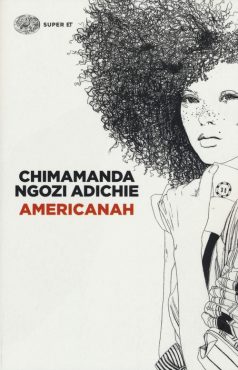Eli McCullough ha messo su un impero usando criteri tutt’altro che irreprensibili; suo figlio Peter, contrario ai metodi paterni, vive di rimpianti; infine Jeanne Anne, bisnipote di Eli, impara a stare al passo coi tempi diventando una ricca petroliera.
Il figlio di Philipp Meyer è un romanzo ambizioso che, attraverso le vicende della famiglia McCullough, ripercorre la storia degli Stati Uniti, dal 1830 ai tempi moderni. Una storia fatta di distruzione e violenza, di soprusi in cui a valere è la legge del più forte, di sottomissioni portate a termine con tutte le armi a disposizione.
I tre protagonisti sono personaggi vissuti in tre epoche diverse che hanno in comune un cognome, un cognome per certi versi scomodo e per qualcuno un peso da portare sulle spalle per non tradire gli avi. I McCullough sono una famiglia potente, e basta pronunciarne il nome per suscitare soggezione reverenziale e devozione.
Il nostro nome conta più che mai. Dove mi aspetto rancore, ricevo rispetto; dove mi aspetto invidia, ricevo incoraggiamento. Non derubare i McCullough: ti uccideranno; non infangare i McCullough: ti uccideranno. Secondo mio padre è giusto così. Gli spiego che siamo nel decimo secolo del secondo millennio.
La parte più avventurosa del romanzo è quella dedicata alla vita di Eli, il capostipite della famiglia, che ne ha passate di tutti i colori: ha visto la sorella e la madre violentate e massacrate dagli indiani, è stato rapito e cresciuto a tutti gli effetti come membro della tribù dei Comanche (i nativi americani) e come loro ha imparato a vivere di furti e uccisioni, a scotennare gli avversari, a scuoiare animali selvatici. Cresce come un indiano e da loro impara il valore e il rispetto.
Poi c’è Peter. Figlio di Eli, è un personaggio di un’umanità fuori dal comune (soprattutto se preso in un tale contesto di violenze e sopraffazioni): è in disaccordo con le maniere forti del capofamiglia e, per non essersi opposto in modo deciso ai modi spietati del padre, sarà ossessionato dal sangue versato e assalito dai rimorsi.
Infine c’è Jeanne Anne, nipote di Peter, unica della famiglia ad avere ereditato l’etica e l’ambizione del bisnonno Eli. Quella che le tocca in eredità è ormai un’azienda in decadenza e, laddove il padre ha puntato ancora sull’allevamento delle vacche, lei ha scelto la modernità e si è data alle trivellazioni, diventando la petroliera più ricca della zona, nonostante le difficoltà per farsi valere in un mondo ancora incentrato sulla superiorità degli uomini (“la natura esigeva che stesse a casa coi bambini”).
Tre personaggi davvero antitetici, ma solo uno mi ha strappato un pezzetto di cuore (e non a caso è a lui che fa riferimento il titolo): Peter. Con il suo essere romanticamente attaccato all’idea di una società senza guerre di possesso, è l’unico depositario dei valori umani di solidarietà e giustizia, un’anima tormentata dalle prepotenze del rude genitore a cui non può porre rimedio.
Non c’è niente di sbagliato in mio padre: lui è l’uomo allo stato naturale. Il problema sono quelli come me, che speravano di sollevarsi dalla nostra condizione istintiva. Speravamo di trascendere la nostra natura.
Un romanzo monumentale (se non altro per la mole), ma con un difetto che ne compromette la scorrevolezza: alcune parti scivolano troppo velocemente, mentre altre sembrano non finire mai. Se la vita di Eli presso i Comanche è molto intrigante e tiene incollati alla pagina, i capitoli dedicati al suo ritorno alla civiltà hanno segnato per me un’impasse non da poco: troppi episodi, troppi nomi di messicani, indiani e texani mi hanno reso davvero difficoltoso seguire con interesse il succedersi degli eventi.
Nel complesso un buon libro, ma da affrontare con la giusta preparazione.