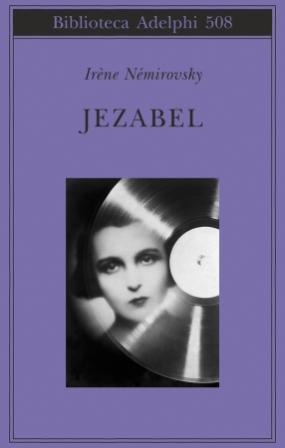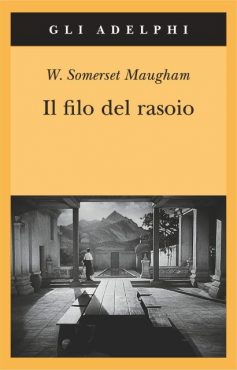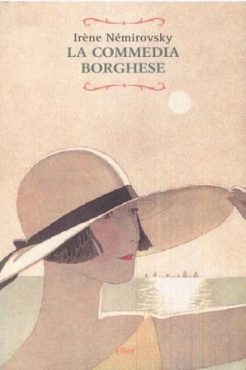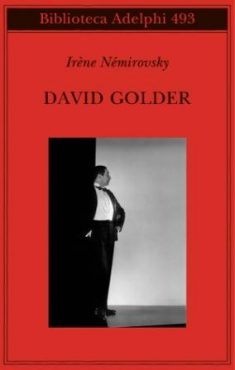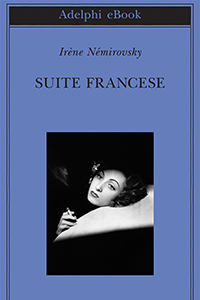Splendida nel suo pallore, Gladys Eysenach deve rispondere dell’omicidio del giovane Bernard Martin, l’amante appena ventenne, ma decide di non difendersi perché il motivo che l’ha spinta a uccidere è ben più vergognoso del delitto passionale di cui è accusata.
Pubblicato nel 1936, Jezabel è un romanzo davvero unico nel suo genere in quanto scritto da una donna, Irène Némirovsky, che denuncia uno dei più deprecabili vizi del genere femminile: la vanità.
Il romanzo si apre su un’aula di tribunale in cui sul banco degli imputati una donna non più bella ma ancora molto affascinante è accusata dell’omicidio di un ragazzo ventenne. Noi lettori non sentiamo la versione dei fatti di Gladys; anzi la sua voce è poco più che un sussurro. Viceversa di lei ascoltiamo la testimonianza di chi la conosce e ci facciamo l’idea di una donna affranta, livida dal dolore, reticente a rispondere tanto è la sofferenza che prova.
Si assiste ad una sorta di processo mediatico, in cui tutti i presenti scrutano la figura e le pose della donna, quasi fosse lei la vittima, mentre l’uccisione del ragazzo è una nota a margine, niente più che una “pallida ombra”.
Ma non è il processo il punto focale della storia. Nei capitoli successivi facciamo un salto temporale di quasi quarant’anni e ripercorriamo le tappe della vita della protagonista fino a scoprire cosa l’ha portata a commettere un omicidio.
In realtà quella donna così delicata nasconde una natura ben più complessa: fragile sì, ma con un obiettivo preciso da raggiungere. Per lei tutta la vita è improntata a conquistare gli uomini (anche quelli sposati) con la grazia, la sensualità e il bisogno di essere accudita proprio di una bambina. Il fascino che esercita sul sesso maschile le dà un potere e una soddisfazione indescrivibile: sottometterli, leggere il desiderio nei loro occhi e poi lasciarli a suo piacimento sono la sua ragion d’essere.
La sua diventa una vera e propria lotta contro il tempo e contro i segni che si fanno via via più evidenti e tradiscono la sua età anagrafica. Invidiosa della bellezza e della giovinezza altrui, è disposta a sacrificare anche la felicità di chi ama di più: sua figlia.
Bisognava essere bella e fare in modo che alle cinque del mattino, in mezzo a tante fanciulle nel fiore degli anni, non si vedessero le rughe affiorare sotto il trucco, né si scorgesse sul suo volto quella maschera di morte che caratterizza le vecchie imbellettate. Mai un momento di abbandono o di stanchezza. Mai riconoscere la propria inferiorità. Ballare, bere, ancora ballare. Costringere un corpo e gambe da sessantenne a negare la malattia e la fatica.
Il romanzo è costellato da una serie di monologhi che la protagonista recita tra sé e sé, in cui è evidente la disperazione di una donna egocentrica, ossessionata dal proprio aspetto fisico. Anche di fronte al dolore della figlia, il suo intento è che non si dica “un tempo era così bella”.
Ancora una volta la Némirovsky svela la mediocrità e le falsità dell’ambiente borghese del suo tempo che dietro a una maschera di perbenismo nasconde una natura crudele, egocentrica e rivolta all’esteriorità.
Un romanzo di un’altra epoca ma che potrebbe essere stato scritto ieri, se si considera che nella società odierna l’apparire sta avendo la meglio sulla bellezza interiore.