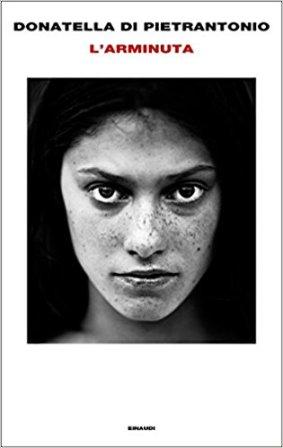L’Arminuta è una ragazzina che, dopo essere stata affidata ad una coppia di zii molto ricchi, viene rimandata dalla famiglia naturale, una famiglia povera. Per lei il distacco dai genitori con cui è cresciuta è una sofferenza che riesce a colmare solo grazie all’affetto di sua sorella Adriana e di un fratello, Vincenzo, che le dà attenzioni non proprio fraterne.
Dopo Bella mia e Mia madre è un fiume, Donatella di Pietrantonio torna in libreria con L’Arminuta, una storia di sofferenza e rinascita. Ha tredici anni l’Arminuta quando viene riconsegnata senza una spiegazione ai suoi genitori biologici. Ha tredici anni e non sa nulla del mondo. Ha tredici anni e non capisce dove abbia sbagliato, cosa abbia fatto per essere abbandonata due volte: dalla sua madre naturale e da quella adottiva. Rispedita al mittente, come un pacco.
Il privilegio che portavo dalla vita precedente mi distingueva, mi isolava nella famiglia. Ero l’Arminuta, la ritornata. Parlavo un’altra lingua e non sapevo più a chi appartenere.
Per capirne il senso d’isolamento, basti pensare che tra i suoi “nuovi” fratelli di sangue ci sono Sergio e “l’altro” – neanche il nome di battesimo ci è dato sapere, tanto la distanza con la protagonista è marcata, insolubile.
L’asprezza dei gesti e delle parole con cui viene accolta nella casa d’origine fanno montare la rabbia e l’odio, ma sono la vita nei campi, la povertà, la fame che giustificano quella rudezza. Ed è solo vivendo quella stessa realtà che l’Arminuta riconoscerà l’autenticità di quei modi bruschi. Lei, cresciuta nella bambagia, tra le lezioni di nuoto e di danza, con la cameretta curata nei minimi particolari, la tv, l’ombrellone in prima fila e due genitori che la ricoprono di attenzioni e di regali, impara a riconoscere i segnali di un sentimento puro anche in mezzo a tanta miseria. Pochi cenni d’affetto, una pacca sulla spalla e una carezza ruvida. Tanto basta per farle capire che in fondo è amata – in un modo che deve ancora imparare a conoscere, però.
Ripetevo piano la parola mamma cento volte, finché perdeva ogni senso ed era solo una ginnastica delle labbra. Restavo orfana di due madri viventi. Una mi aveva ceduta con il suo latte ancora sulla lingua, l’altra mi aveva restituita a tredici anni. Ero figlia di separazioni, parentele false o taciute, distanze. Non sapevo più da chi provenivo. In fondo non lo so neanche adesso.
Questo romanzo breve racconta le luci e le ombre di un’esistenza di miseria, sofferenza e speranze disilluse. E la luce più splendente sta nell’incontro con Adriana, una sorella che le dimostra subito simpatia, solidarietà, ma soprattutto protezione. È paradossale che con quattro genitori alle spalle, è tra le braccia di questo scricciolo di sorella che la protagonista trova un barlume di serenità. Adriana è, a mio parere, il personaggio meglio caratterizzato, con i suoi slanci di bontà d’animo, il bisogno di condivisione, le gelosie infantili e la paura di essere lasciata indietro dalla sorella maggiore. Ed è lei ad aprirle gli occhi sulle vere ragioni per cui è stata riportata indietro dalla famiglia adottiva. Glielo dice così, a brutto muso, spinta da un sentimento d’invidia, con quel pizzico di cattiveria che solo a una sorella si può perdonare.
Arrivata all’ultima pagina, ho pensato che il finale non c’entrasse niente con il resto. Eppure ha continuato a frullarmi nella mente per giorni, e alla fine mi sono detta che sta lì il senso del romanzo, nella dicotomia tra un mondo rurale, sporco, ineducato ma genuino, e quello borghese, raffinato ma egoistico, privo di veri slanci affettivi.
Uno stile essenziale quello della Di Pietrantonio, che arriva dritto al cuore delle cose, sostenuto da un dialetto che si impara presto a maneggiare e che si ritrova, se possibile ancor più vitale e colorito, nel seguito Borgo Sud.