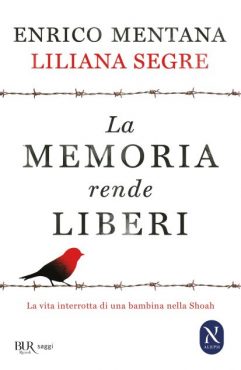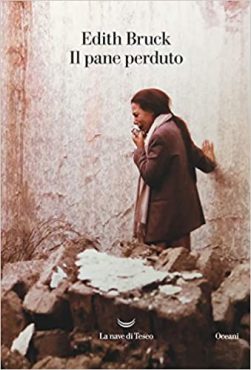Nel giorno del suo ottantacinquesimo compleanno, Miriam sente che i fantasmi del passato sono tornati a tormentarla ed è arrivato il momento per lei di raccontare le sue origini di zingara, la lotta per la sopravvivenza durante la guerra e le difficoltà di riprendere a vivere nel periodo post-bellico.
Io non mi chiamo Miriam è un romanzo di Majgull Axelsson che punta l’obiettivo su una realtà di cui non si accenna nemmeno quando si parla di Olocausto e di campi di sterminio: la situazione dei rom.
Nella versione romanzata dell’autrice svedese, Malika si salva la vita assumendo l’identità di un’ebrea morta, Miriam, e paradossalmente si sente più al sicuro nei panni di un’ebrea che in quelli di zingara perché, se entrambe le categorie sono in cima alla lista nera dei nazisti, i rom sono invisi anche a tutte le prigioniere di Ravensbrück ed è con loro che la protagonista deve convivere ogni giorno.
Solo in quel momento aveva capito quanto desiderava morire, poter precipitare una volta per tutte nell’abisso nero… Perché aveva lottato tanto per continuare a vivere?
Ma la realtà di cui parla la Axelsson non si ferma alle atrocità della guerra, ma fa riferimento anche al difficile periodo post-bellico in cui i rom non avranno vita facile: nella sola Svezia (come pure nei Paesi dell’Est) erano vessati e perseguitati, le donne erano costrette ad abortire e venivano sterilizzate, i loro figli erano ghettizzati nelle scuole perché non si mischiassero con i bambini locali. Il tutto per invitarli “gentilmente” a lasciare il Paese e salvaguardare la sicurezza e la moralità del posto.
È su questi due binari che procede la narrazione, saltellando tra l’esperienza nei lager di Auschwitz e Ravensbrück o sul treno verso l’inferno e la situazione socio-politica a Nässjö (in Svezia) nell’estate del 1948, quando la folla inferocita assale i “tattare”, fa irruzione nei loro appartamenti, li malmena.
Ma c’è un terzo piano temporale ed è quello da cui si dipana il racconto. Miriam è ormai una vecchia signora, ha appena compiuto ottantacinque anni e ripercorre il suo passato, stanca di vivere in una grande menzogna e pentita di aver costretto i suoi cari a credere a quella stessa menzogna. È come se i fantasmi del suo passato spingessero per uscire fuori, per venire alla luce una volta e per sempre. E lei, Miriam, non riesce più a controllare lo scorrere delle immagini atroci che hanno segnato il suo cammino e sceglie come interlocutrice l’affettuosa nipote Camilla, curiosa di sapere. E a quella curiosità, Miriam risponde con toni bruschi: le grida in faccia la verità.
Miriam non la lascia andare. Al contrario, scuote la mano della nipote a ritmo con ogni parola:
«Lo capisci o no? È successo davvero. Era tutto reale. Era un altro mondo e io non ci voglio tornare. Non ne ho nessuna intenzione!»
Ma è già troppo tardi.
E quelle grida sono indirizzate a Camilla ma arrivano forti e chiare anche a noi lettori; Miriam strattona anche il nostro polso, per aprirci gli occhi, per ricordarci che questi fatti non sono solo argomento per un romanzo commovente, ma è nella storia di ciascuno di noi.
E anche se quella di Miriam è una storia romanzata, anche se Didi, Anuncha, Else e Sylviane sono personaggi di fantasia, ce ne sono state a milioni di persone come loro: bambini sottoposti agli esperimenti del dottor Mengele, donne morte di fame o di tifo esantematico (Anna Frank è l’esempio più lampante), prigionieri che non hanno avuto più la forza di combattere e si sono arresi quando i russi erano lì lì per portarli in salvo. Persone il cui sacrificio va ricordato, sempre. E questo romanzo permette di farlo.