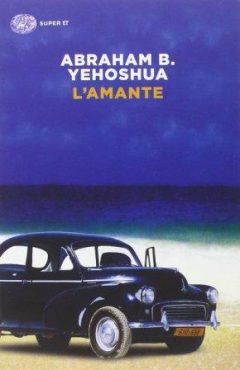Amal, nata nel campo profughi di Jenin, ripercorre la storia della sua famiglia, dei nonni Yehya e Bassima, dei genitori Hassan e Dalia, dei fratelli Yussef e Isma’il, in una Palestina assediata dall’esercito israeliano.
Ogni mattina a Jenin è un romanzo familiare dove la storia della famiglia Abulheja si intreccia con quella sanguinosa della Palestina in guerra e dei tanti profughi sfuggiti alla furia omicida dell’avanzata israeliana dopo la fondazione dello Stato d’Israele nel 1948. La loro storia – che è poi la stessa di tanti profughi che ancora oggi popolano i campi profughi in Libano, in Giordania e in Siria – è un unico racconto fatto di espropriazione, dell’essere denudati della propria umanità, essere buttati come spazzatura in campi profughi indegni dei topi. Del’essere lasciati senza diritti, senza casa né nazione, mentre il mondo si voltava dall’altra parte a guardare e ad applaudire l’esultanza degli usurpatori che proclamavano il nuovo stato che chiamavano Israele.
Ma anche se ad ogni pagina c’è la guerra, questo libro è soprattutto incentrato sui buoni sentimenti. Nonostante le ferite inflitte, nonostante il dolore, nonostante la perdita delle persone amate, nonostante la rabbia per essere stati espropriati di ciò che è tuo, che hai costruito dal niente con le tue mani, che ti spetta di diritto, nonostante tutto questo i protagonisti di questo romanzo non abbandonano mai la speranza. La speranza di riappropriarsi della propria casa, della propria terra. Una speranza che è stata dei nonni e dei genitori, morti prima di vedere coronare un sogno, e che sarà l’unica eredità lasciata a chi sopravvive ad essi.
Amal, nata profuga, rincorre lo stesso sogno di tornare ad una patria che non ha mai conosciuto, spinta da una nostalgia atavica per un’identità che le è stata portata via prima ancora che venisse al mondo, ma che in qualche modo l’ha resa incompleta.
Nella migliore tradizione del romanzo corale, anche qui a raccontare è ora un personaggio ora un altro, ora il narratore onnisciente che sbroglia i fili della matassa e ci regala un quadro d’insieme unico, indimenticabile. In questo modo, noi lettori sappiamo poco alla volta tutto ciò che serve sapere: le paure, le speranze, i sospetti, l’amore.
Susan Abulhawa, nata da una famiglia palestinese in fuga e cresciuta in un orfanotrofio di Gerusalemme (come la Amal del romanzo) per poi trasferirsi negli Stati Uniti, racconta questa storia con delicatezza, ma anche con una crudezza che è propria di chi quell’orrore l’ha vissuto in prima persona o l’ha visto negli occhi dei propri cari. E, seppur mai con toni aggressivi, l’autrice non risparmia un giudizio negativo nei confronti di quanti in Occidente hanno semplicemente scelto di schierarsi sul fronte opposto, mostrandosi indifferente verso un popolo espropriato e massacrato.
Quella che per noi è semplice paura per altri è terrore, perché ormai siamo anestetizzati dai fucili che abbiamo continuamente puntati contro. E il terrore che abbiamo conosciuto è qualcosa che pochi occidentali proveranno mai. L’occupazione israeliana ci ha esposti fin da piccoli a emozioni estreme, e adesso non possiamo che sentire in maniera estrema.
Le radici del nostro dolore affondano a tal punto nella perdita che la morte ha finito per vivere con noi, come se fosse un componente della famiglia che saremmo ben contenti di evitare, ma che comunque fa parte della famiglia. La nostra rabbia è un furore che gli occidentali non possono capire. La nostra tristezza può far piangere le pietre.
Oltre che per l’indiscussa bellezza letteraria dell’opera, Ogni mattina a Jenin è un libro che è doveroso leggere, per poter giudicare con cognizione di causa la situazione politica di due popoli eternamente in lotta tra loro, serrati in una reciproca catena di violente ritorsioni di cui sono vittime i tanti civili innocenti.